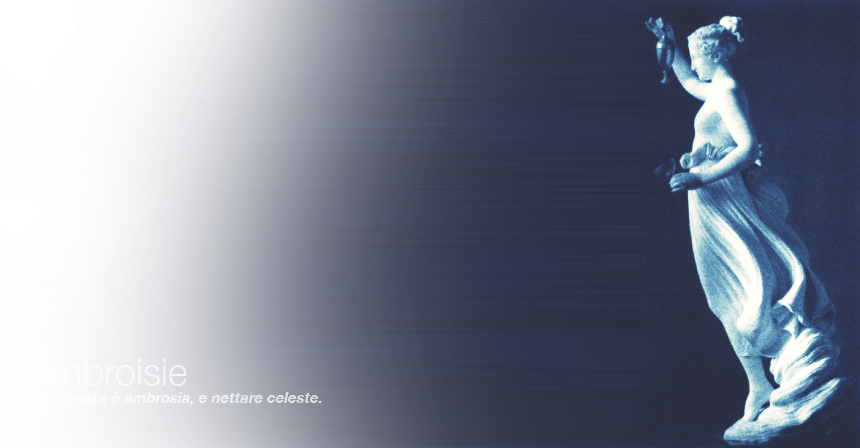da 'La Regione' del 31.3.2011
«Andiamo. Sì Andiamo. (Non si muovono)» . L’attualità del
celebre finale di Beckett quando si parla di giovani che non hanno il
coraggio, di partire, di andare, restando imprigionati in una statica
atmosfera di indecisione e paura. È con questa citazione che si apre la
‘webseries’ Bymyside (online da giovedì 29 marzo il primo
episodio su Youtube) che, con un linguaggio innovativo e di qualità, ci
racconta la storia di tre trentenni che devono fare i conti con la
sparizione del cantante del loro gruppo rock.
Passano le nottate appoggiati all’entrata di un grande supermercato di periferia, tra birre, skate, recriminazioni e domande. Lo sguardo della camera è fisso sulle vite di questi tre amici, senza retorica, senza presa di parte, senza mutamenti, come le luci.
Saranno loro, Teo (Pier Luigi Pasino), Bozo (Jacopo Bicocchi) e Sparo (Matteo Alfonso, che in Ticino ha iniziato a collaborare con Cambusa Teatro di Locarno), che a poco a poco faranno emergere la loro voglia di riscatto, o rispettivamente il vuoto dal quale si sentono invasi, svelando anche il mistero legato alla scomparsa di Flippo.
 Il film è stato prodotto, diretto e co-sceneggiato da Flavio
Parenti (nel ruolo di Flippo), attore italiano emergente che vedremo
prossimamente sul grande schermo nel nuovo film di Woody Allen, To
Rome with love . Abbiamo intervistato il regista di Bymyside
incuriositi dal fenomeno di questa ‘webseries’ che, in un mese dal suo
annuncio sulla rete attraverso i social network e il sito ufficiale,
conta già migliaia di fan. Questo grazie anche alla comunicazione creata
attorno all'evento, volta a alimentare continuamente l’aspettativa per
un prodotto di qualità (dagli attori al montaggio) distribuito in
maniera assolutamente non elitaria.
Il film è stato prodotto, diretto e co-sceneggiato da Flavio
Parenti (nel ruolo di Flippo), attore italiano emergente che vedremo
prossimamente sul grande schermo nel nuovo film di Woody Allen, To
Rome with love . Abbiamo intervistato il regista di Bymyside
incuriositi dal fenomeno di questa ‘webseries’ che, in un mese dal suo
annuncio sulla rete attraverso i social network e il sito ufficiale,
conta già migliaia di fan. Questo grazie anche alla comunicazione creata
attorno all'evento, volta a alimentare continuamente l’aspettativa per
un prodotto di qualità (dagli attori al montaggio) distribuito in
maniera assolutamente non elitaria.
Come nasce questo progetto?
«Nasce da una realtà che ha vissuto l’autore, Pier Luigi Pasino. Ha radicato in sé quella sensazione e ha poi scritto il testo, inizialmente per il teatro. C’era una bella necessità, voglia di raccontare quella staticità. Insieme abbiamo co-sceneggiato la stesura cinematografica».
Quello che colpisce è soprattutto l’atmosfera...
«Sì, si entra a poco a poco nell’umanità dei personaggi. Soprattutto si tenta di scavare a fondo i motivi per spiegare quello che è successo. È profondo. E questa profondità si fonde in uno strano connubio con un meccanismo di fruizione in pillole, veloce, superficiale».
È questo che piace del vostro progetto. La gente che fruisce dei prodotti veloci di Internet non per forza è alla ricerca di prodotti superficiali, anzi.
«Sono d’accordo. Siamo a un bivio. Il virale è quanto di più visto, tutti si sono spinti in una fruizione usa e getta, che funziona, ma quanto hai fatto non serve poi all’umanità. Siamo in un momento in cui possiamo ancora mostrare che si può fare anche dell’altro attraverso la rete. Se il nostro esperimento piace, si creerà forse un nuovo ramo di Internet, fatto di contenuti anziché viralità. Penso che sia fondamentale per non trovarsi tra vent’anni unicamente con del marketing senza la narrazione, niente catarsi e solo vendita».
Questo è un anno particolarmente produttivo anche per la tua professione d’attore...
«Ciò che sto facendo adesso, Un matrimonio di Pupi Avati, è una delle esperienze più belle. Passo dall’essere ventenne a settantacinquenne, e attraverso tutte le fasi della vita.
Ma in fondo tutte le esperienze hanno qualcosa. Dipende anche da quanto tu sia aperto in quel momento e predisposto ad accettarle. Lavorare con Tilda Swinton ( Io sono l’amore di Luca Guadagnino) piuttosto che con Murray Abraham e Peter Greenway ( Goltzius and the Pelican Company ) o Woody Allen, sono tutte esperienze strepitose».
E com’è stato lavorare con questi due grandi registi?
«Greenway è molto gentile. Lo incontri alle otto di mattina, alle tre di notte o a mezzogiorno ed è sempre uguale. Una specie di costante, la stessa energia. Ma quando lavori sei in un caos creativo impressionante. Lavorare con Woody Allen è meraviglioso, non è solo un grande regista, ma un inventore, un autore strepitoso. Recitare con lui, avere degli scambi di battute, è stato incredibile».
E per tornare al mondo che Flavio Parenti ha creato attraverso Bymyside , la voglia di andare e la paura di restare sono on line. Un cinema d’autore in tredici episodi che racconta lo smarrimento e l’anima rock della nostra generazione. «Te ne vuoi andare? Dove? Non lo so, dove mi fanno fare quel che ho voglia di fare. E che cosa hai voglia di fare? Qualcosa che mi fa star bene».
Passano le nottate appoggiati all’entrata di un grande supermercato di periferia, tra birre, skate, recriminazioni e domande. Lo sguardo della camera è fisso sulle vite di questi tre amici, senza retorica, senza presa di parte, senza mutamenti, come le luci.
Saranno loro, Teo (Pier Luigi Pasino), Bozo (Jacopo Bicocchi) e Sparo (Matteo Alfonso, che in Ticino ha iniziato a collaborare con Cambusa Teatro di Locarno), che a poco a poco faranno emergere la loro voglia di riscatto, o rispettivamente il vuoto dal quale si sentono invasi, svelando anche il mistero legato alla scomparsa di Flippo.
 Il film è stato prodotto, diretto e co-sceneggiato da Flavio
Parenti (nel ruolo di Flippo), attore italiano emergente che vedremo
prossimamente sul grande schermo nel nuovo film di Woody Allen, To
Rome with love . Abbiamo intervistato il regista di Bymyside
incuriositi dal fenomeno di questa ‘webseries’ che, in un mese dal suo
annuncio sulla rete attraverso i social network e il sito ufficiale,
conta già migliaia di fan. Questo grazie anche alla comunicazione creata
attorno all'evento, volta a alimentare continuamente l’aspettativa per
un prodotto di qualità (dagli attori al montaggio) distribuito in
maniera assolutamente non elitaria.
Il film è stato prodotto, diretto e co-sceneggiato da Flavio
Parenti (nel ruolo di Flippo), attore italiano emergente che vedremo
prossimamente sul grande schermo nel nuovo film di Woody Allen, To
Rome with love . Abbiamo intervistato il regista di Bymyside
incuriositi dal fenomeno di questa ‘webseries’ che, in un mese dal suo
annuncio sulla rete attraverso i social network e il sito ufficiale,
conta già migliaia di fan. Questo grazie anche alla comunicazione creata
attorno all'evento, volta a alimentare continuamente l’aspettativa per
un prodotto di qualità (dagli attori al montaggio) distribuito in
maniera assolutamente non elitaria.Come nasce questo progetto?
«Nasce da una realtà che ha vissuto l’autore, Pier Luigi Pasino. Ha radicato in sé quella sensazione e ha poi scritto il testo, inizialmente per il teatro. C’era una bella necessità, voglia di raccontare quella staticità. Insieme abbiamo co-sceneggiato la stesura cinematografica».
Quello che colpisce è soprattutto l’atmosfera...
«Sì, si entra a poco a poco nell’umanità dei personaggi. Soprattutto si tenta di scavare a fondo i motivi per spiegare quello che è successo. È profondo. E questa profondità si fonde in uno strano connubio con un meccanismo di fruizione in pillole, veloce, superficiale».
È questo che piace del vostro progetto. La gente che fruisce dei prodotti veloci di Internet non per forza è alla ricerca di prodotti superficiali, anzi.
«Sono d’accordo. Siamo a un bivio. Il virale è quanto di più visto, tutti si sono spinti in una fruizione usa e getta, che funziona, ma quanto hai fatto non serve poi all’umanità. Siamo in un momento in cui possiamo ancora mostrare che si può fare anche dell’altro attraverso la rete. Se il nostro esperimento piace, si creerà forse un nuovo ramo di Internet, fatto di contenuti anziché viralità. Penso che sia fondamentale per non trovarsi tra vent’anni unicamente con del marketing senza la narrazione, niente catarsi e solo vendita».
Questo è un anno particolarmente produttivo anche per la tua professione d’attore...
«Ciò che sto facendo adesso, Un matrimonio di Pupi Avati, è una delle esperienze più belle. Passo dall’essere ventenne a settantacinquenne, e attraverso tutte le fasi della vita.
Ma in fondo tutte le esperienze hanno qualcosa. Dipende anche da quanto tu sia aperto in quel momento e predisposto ad accettarle. Lavorare con Tilda Swinton ( Io sono l’amore di Luca Guadagnino) piuttosto che con Murray Abraham e Peter Greenway ( Goltzius and the Pelican Company ) o Woody Allen, sono tutte esperienze strepitose».
E com’è stato lavorare con questi due grandi registi?
«Greenway è molto gentile. Lo incontri alle otto di mattina, alle tre di notte o a mezzogiorno ed è sempre uguale. Una specie di costante, la stessa energia. Ma quando lavori sei in un caos creativo impressionante. Lavorare con Woody Allen è meraviglioso, non è solo un grande regista, ma un inventore, un autore strepitoso. Recitare con lui, avere degli scambi di battute, è stato incredibile».
E per tornare al mondo che Flavio Parenti ha creato attraverso Bymyside , la voglia di andare e la paura di restare sono on line. Un cinema d’autore in tredici episodi che racconta lo smarrimento e l’anima rock della nostra generazione. «Te ne vuoi andare? Dove? Non lo so, dove mi fanno fare quel che ho voglia di fare. E che cosa hai voglia di fare? Qualcosa che mi fa star bene».