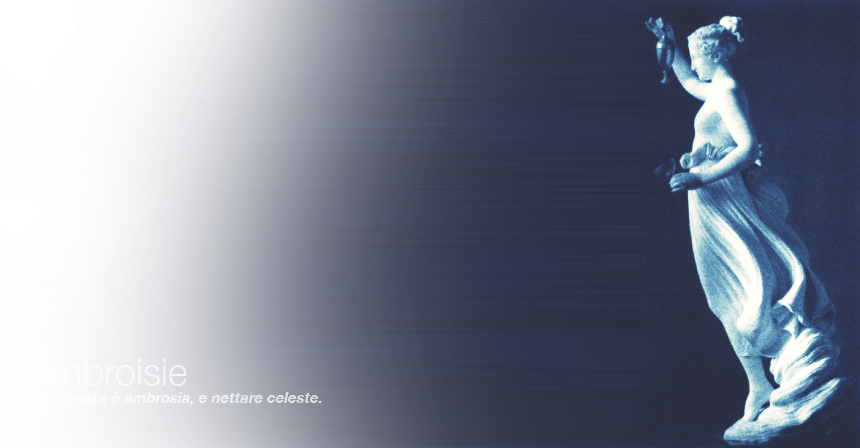da 'La Regione Ticino' dell'11 luglio 2012
Ben 1’161 spettacoli fino al 28 luglio annoverano il Festival d’Avignone
tra i capoluoghi mondiali del teatro, dove albergano due anime con un
programma ufficiale e uno ‘off’. Alla sua 66esima edizione, l’evento
trasforma la provenzale città dei papi in pulsante località artistica
dove nascono palcoscenici dalle cantine, le case si aprono per diventare
bar o ristoranti. Numeroso il pubblico che risponde alla vasta offerta
del cartellone con spettacoli di ogni genere. Nostra visita nella magica
località francese.
Arrivando ad Avignone si percepisce immediatamente che la provenzale
città dei papi è stata invasa e conquistata da quel teatro democratico
difeso un tempo da Jean Vilar, fondatore del Festival d’Avignone nel
1947, oggi alla sua 66esima edizione. Capoluogo regionale del
dipartimento Vaucluse, Avignone in occasione del festival diventa dal 7
al 28 luglio capoluogo artistico europeo.
Due anime albergano il teatro avignonese, e l’appellativo
impietoso che portano non è che un indizio alla diffidenza e differenza
che reciprocamente le contraddistingue: il festival In e quello Off.
Facilmente riassumibili in Ufficiale e Non.
Il Festival Off
Basta citare il numero degli spettacoli che lo compongono per
farsi un’idea della vastità del programma: 1161! Mura, portoni e
lampioni sono tappezzati da locandine che raccontano questo festival
‘alternativo’, nato autonomamente negli anni sessanta su iniziativa di
alcuni artisti avignonesi stufi di non essere invitati all’In di Vilar, e
oggi più vivo che mai. Le pièce rappresentate gridano quest’anima
sovversiva e popolare, dove ognuno porta la sua voce e il suo teatro:
sui muri leggiamo a lettere cubitali che Godot est arrivé e che Juliette hait Romeo
. Il teatro non è morto e non è per pochi! Lungo l’arteria principale
(Rue de la République) che ci porta verso il centro della città
fortificata – la Place de l’Horloge – e per tutti gli stretti vicoli, le
compagnie si esibiscono in una parata degna di quei giullari che
attiravano a corte gli spettatori. Gli attori, vestiti per la scena, ci
richiamano alla propria corte, grazie anche a un volantinaggio
inarrestabile e invincibile. Per districarsi nell’ardua scelta un
programma è distribuito gratuitamente, e la scuola elementare Thiers si
muta nel Village du Off dispensando ogni informazione.
Tutto sembra trasformarsi in questo mese estivo ad Avignone:
nascono teatri dalle cantine, le case si aprono per diventare bar e
ristoranti, gli abitanti si riscoprono imprenditori e tutto ruota
attorno all’arte. La rue des Tenturiers è il centro pulsante di questa
kermesse, tavolini in ferro battuto e vecchie sedie colorate, cucina
etnica e du terroir , librerie gremite di volumi antichi e
terrazze assolate ospitano il fiume di festivalieri che si incontrano e
opinano sulla qualità di quanto appena visto.
Gli spettacoli sono di tutti i generi, e qualità e serietà non
sono sempre all’altezza della quantità. Se infatti, per partecipare al Festival In bisogna godere di comprovata fama internazionale in ambito artistico, una compagnia può partecipare all’ Off
piuttosto facilmente: basta avere i soldi per affittare una sala. Il
prezzo da pagare è alto, ma la possibilità di essere visti dai direttori
artistici delle sale parigine e rischiare di essere selezionati per la
stagione successiva è impagabile.
Il Festival In

Vincent Baudriller e Hortense Archambault, direttori artistici,
propongono quest’anno un programma particolarmente europeo con un occhio
di riguardo per l’Inghilterra. Il teatro ritorna alla sacra importanza
del testo, e lo vediamo già dalla prima proposta in scena nella Corte
d’Onore del Palazzo dei papi in apertura alla 66esima edizione:
l’adattamento alla scena de Il Maestro e Margherita , il celebre
romanzo del russo Michail Bulgakov, montata per l’occasione dall’artista
associato del Festival, l’inglese Simon McBurney.
Un capolavoro della
letteratura che si fa capolavoro di scena, uno spettacolo che racconta
magistralmente della compassione, della debolezza, del demonio e
dell’amore, la poesia di Bulgakov diventa parola viva su un palco dalla
scenografia eccezionale (il Palazzo dei papi), e noi voliamo su Mosca
insieme a Margherita accompagnati dalle parole del Maestro .
All’In si possono vedere, tra gli altri: l’esposizione Rachel, Monique di Sophie Calle, Il Gabbiano (Chekov) di Arthur Nauzyciel, i pirandelliani Sei personaggi in cerca d’autore di Stéphane Braunschweig, Refuse the hour di William Kentridge, Nouveau Roman di Christophe Honoré, e The four seasons restaurant di Romeo Castellucci.
 Un programma appetitoso e per palati fini, ordinato e ben
presentato, che vive insieme alla vitalità del Festival Off, forse più
disordinato, meno scontato e più arrabattato.
Un programma appetitoso e per palati fini, ordinato e ben
presentato, che vive insieme alla vitalità del Festival Off, forse più
disordinato, meno scontato e più arrabattato.
È ciò che conferisce lo charme a questa città dal duplice volto,
dove sacro e profano si fondono a dimostrare che l’arte, ebbene sì, e
per fortuna, è anche questo.